Intervista a Gian Marco Montesano – Di Fabio Cavallucci
Galleria Civica di Trento - Scuola di Pittura Intervista di Fabio Cavallucci «Disturbo artistico di massa»

Gian Macro Montesano è un
personaggio che varrebbe la pena ascoltare per ore mentre parla.
Sarà lui a dirigere la «Scuola di
pittura» che la Galleria Civica ha deciso di
allestire in questi mesi estivi per incrementare le passioni e le
professioni di un'arte che rappresenta il «figurativo» del tempo
che vive. Montesano sarà presente all'inaugurazione di venerdì 6
giugno e certamente prenderà la parola. Ansate ad ascoltarlo,
perché non può essere interpretato da un giornalista. Va ascoltato
di persona, perché vi spiegherà che la pittura così come intesa dai
Sacri testi, oggi altro non è che «Disturbo artistico
di massa».
Per questo abbiamo deciso di parlare di lui tramite un'intervista
che gli ha fatto per noi il direttore della galleria Civica
Fabio Cavallucci.
Fabio
Cavallucci: Cosa ha da dire ancora la pittura nel
2007?
Gian Marco
Montesano: La pittura storicamente intesa (non mi
riferisco tanto ai quadri, quanto alla mentalità), la pittura
umanistica, secondo me non solo non ha più nulla da dire, ma è
morta. E il morto,  come si sa, non
parla. Però si lascia esaminare, si lascia sottoporre ad autopsia.
Qualcuno potrebbe obiettare che il mercato, i musei, ecc.
sostengono il contrario. Certo, è ovvio, il valore della pittura si
prolunga per forza di inerzia. Ma per quel che è della produzione
di pensiero attuale, la pittura è fuori gioco. Nei musei di scienze
naturali troviamo gli scheletri dei dinosauri, li ammiriamo, ma non
operiamo tenendo conto del dinosauro. La pittura non è morta per
una questione di moda, di gusto, o chissà per quale altra strana
ragione, ma perché le è stato tolto il terreno sotto i piedi: è
venuto meno tutto quel mondo, tutto il sistema di valori che la
esprimeva, che la giustificava. E che mondo era? Era il mondo
umanistico, cioè il mondo dei grandi postulati, dei grandi
progetti, dell'utopia, che genera le avanguardie - sia politiche
che artistiche - della posizione critica, estetica, politica,
sociale. Nel mondo, nella società contemporanea, di questi
riferimenti non vi è più traccia, tutto è cambiato.
come si sa, non
parla. Però si lascia esaminare, si lascia sottoporre ad autopsia.
Qualcuno potrebbe obiettare che il mercato, i musei, ecc.
sostengono il contrario. Certo, è ovvio, il valore della pittura si
prolunga per forza di inerzia. Ma per quel che è della produzione
di pensiero attuale, la pittura è fuori gioco. Nei musei di scienze
naturali troviamo gli scheletri dei dinosauri, li ammiriamo, ma non
operiamo tenendo conto del dinosauro. La pittura non è morta per
una questione di moda, di gusto, o chissà per quale altra strana
ragione, ma perché le è stato tolto il terreno sotto i piedi: è
venuto meno tutto quel mondo, tutto il sistema di valori che la
esprimeva, che la giustificava. E che mondo era? Era il mondo
umanistico, cioè il mondo dei grandi postulati, dei grandi
progetti, dell'utopia, che genera le avanguardie - sia politiche
che artistiche - della posizione critica, estetica, politica,
sociale. Nel mondo, nella società contemporanea, di questi
riferimenti non vi è più traccia, tutto è cambiato.
Se l'umanesimo è finito, cosa succederà dopo?
A livello artistico oggi, o per meglio dire, da venti anni a questa
parte, si parla di post-human. Questo perché evidentemente si
registra la fine del mondo umanistico, umano, qualcuno aveva detto
"troppo umano", e nel contempo l'attesa di un mondo che deve ancora
venire. Ecco la grande Babele dei linguaggi, la mancanza di
riferimenti certi. Quando un pensiero complessivo decade, giace
inutilizzabile, e qualcosa di nuovo, veramente formato ancora non
si manifesta, in questo interregno, nel vicariato, nel momento di
transizione, ci sono comunque molte diverse espressioni
individuali. Pur ritenendo inutile leggere i fondi del caffé per
scoprire cosa sarà il mondo che verrà, una certezza esiste: non
sarà mai come il mondo che ci siamo lasciati alle spalle; non si
più pensare al ritorno, per esempio, delle vecchie utopie
politiche, dei grandi postulati che organizzano il mondo. Tutti i
riferimenti umanistici sono fuori gioco. L'arte, sul versante delle
discipline "plastiche" - come le si definiva una volta -, la quale
si esprimeva con la pittura, ha iniziato a decadere con la fine
della modernità, con la fine dell'Ottocento; ha cominciato ad
uscire dalla cornice, ad integrare materiali eterogenei, e dunque
non è più quella comunemente intesa nel vecchio mondo umanistico.
Poi, finita la modernità, c'è la postmodernità, e oggi siamo ben
oltre la classica definizione di postmoderno che fu, perché
postmoderno già non è più un referente saldo sul quale fare
affidamento, ma è una delle tante cose che "galleggiano" in mezzo
alle altre.
Allora perché continui a dipingere, fondi un'accademia di
pittura, e ci sono ancora molti giovani che dipingono… come si
giustifica questa inerzia della pittura?
Potrei avere
una risposta rapidissima ed esaustiva: so benissimo che il mondo si
colloca ormai oltre il postmoderno, ma da buon reazionario mi fermo
sui miei godimenti, sui miei piaceri. Li conservo finché durano.
Temo però che questa risposta non sia sufficiente, perché non lo è
neppure per me, e in realtà non si tratta di questo. Purtroppo so
che la risposta del reazionario sarà sufficiente per tante, troppe
persone.  Pazienza. Se
fosse vero che sono un reazionario, reagirei a qualcosa che ho
analizzato bene: ho fatto una ricognizione del mondo, sono
perfettamente a conoscenza di quello che succede, ma con un atto di
volontà lucida e deliberata decido di reagire. Ti dirò, questa è
una classica posizione da grande artista, da non confondere con le
posizioni sclerotiche di quanti continuano a riferirsi a valori, a
modelli che tali non sono più per nessuno. Ecco perché, e si
accaniscono contro l'ultima contemporaneità; ne è un esempio l'odio
di alcuni nei confronti di Cattelan.
Pazienza. Se
fosse vero che sono un reazionario, reagirei a qualcosa che ho
analizzato bene: ho fatto una ricognizione del mondo, sono
perfettamente a conoscenza di quello che succede, ma con un atto di
volontà lucida e deliberata decido di reagire. Ti dirò, questa è
una classica posizione da grande artista, da non confondere con le
posizioni sclerotiche di quanti continuano a riferirsi a valori, a
modelli che tali non sono più per nessuno. Ecco perché, e si
accaniscono contro l'ultima contemporaneità; ne è un esempio l'odio
di alcuni nei confronti di Cattelan.
Possiamo fare qualche nome di questi reazionari autentici
che hanno capito come va il mondo ma dicono "io me ne
frego"?
È difficile trovare un'artista che si serva
attualmente della pittura con la netta consapevolezza di tutto
quello che stiamo dicendo e che si ritenga l'ultimo testimone di un
mondo morto, assumendo una posizione eroica, straordinaria. Devo
dire che attualmente di queste posizioni non ne vedo.
Nemmeno per esempio Clemente, Cucchi, De
Maria?
Per quanto riguarda Clemente, non ho gli
strumenti di analisi sufficienti per esprimermi; ma temo che gli
altri due siano ancora convinti dei valori umanistici della
pittura. Infatti i loro riferimenti sono tutti interni alla storia
dell'arte; la quale non ha più luogo d'essere, se non come il
dinosauro, ma operativamente non serve più a nessuno, non interessa
più a nessun giovane che oggi opera nella moltitudine. Questo
problema è delicatissimo, è come una partita a scacchi; sembra
quasi che aprendo un'accademia di pittura non si abbiano che due
mosse a disposizione: asserire che si compie un'operazione
paradossale, ultra-postmoderna, cioè fondata sull'ironia e
l'autoironia che distruggono l'aura seriosa dell'artista, oppure
dichiararsi eroicamente reazionari, affermare di aver capito tutto
e proprio per questo decidere di suicidarsi. È evidente che se
dichiariamo l'accademia di pittura come paradosso e come ironia
oppure come ultimo grido reazionario, evitiamo lo scacco matto, ma
non ci facciamo molti amici. Però in definitiva sono due mosse
povere, si esauriscono in sé. In realtà c'è una terza mossa che è
possibile fare, complicatissima da spiegare, che consiste nel
riuscire almeno a far intuire che si possono ancora usare gli
strumenti della pittura per fare un qualcosa che pittura, così come
nel vecchio mondo la si intendeva, non è più.
E quindi cos'è, cosa può essere?
Occorre
secondo me - è soltanto un'ipotesi, una mossa complicata - partire
da alcuni presupposti: capire che già il Novecento, cioè le
avanguardie, l'umanesimo morente che esprimeva le ultime due grandi
utopie politiche dell'occidente - le quali poi faranno la fine
orrenda che hanno fatto - era ancora carico di volontà critica del
mondo, voleva rifare l'arte, ricostruirla, prefigurava il nuovo
senza però produrre la fine della cultura umanistica. Riuscirono a
produrre soltanto Picasso, la figura dominante che informa di sé
l'ultimo bagliore di quella cultura. Però nel Novecento si sono
prodotti i due fenomeni che già indicavano la necessità di andare
oltre, di abbandonare i vecchi riferimenti, fossero pure
d'avanguardia, per andare altrove, in un non-luogo che non
conosciamo. Uno è Walt Disney, una figura artistica certamente non
meno nota di Picasso, tutt'altro. E poi colui che sposta tutto il
problema nella terra di nessuno: Andy Warhol.
E Duchamp?
Duchamp, in fondo, appartiene ancora
al concetto di avanguardia, di volontà critica, di sensatezza che
mostra l'insensatezza dei vecchi postulati da rinnovare, al fine di
rendere estetico ciò che non lo era. Con Duchamp siamo comunque di
fronte alla figura del vecchio mondo - certo la più estrema, più
alta, l'ultima. Ma si tratta sempre del vecchio concetto
umanistico; con lui siamo addirittura al taumaturgo, cioè l'artista
talmente importante che basta il suo sguardo e il suo tocco per
resuscitare gli oggetti a nuova vita estetica. Con Andy Wahrol
assistiamo alla distruzione dell'idea dell'artista, della
creazione. Benché sia lontanissimo da Picasso, e più vicino alle
problematiche attuali, sento di dover collocare Duchamp tra ciò
 che è morto.
che è morto.
Ma stavamo parlando di pittura, e credo di dover chiudere i conti
con Picasso. Oggi egli è l'artista i cui postulati sono i meno
praticati al mondo; è l'artista più inutile che esista oggi.
Inutile a chi? Non alle forze inerziali del mercato, è ovvio. ma ai
produttori di pensiero, a tutti coloro che hanno vent'anni e che
vivono nella moltitudine del mondo. Ditemi se aprendo una rivista
specializzata trovate un artista che dimostri di avere in memoria
Picasso. Picasso invece lo troviamo in tutti gli artisti di
provincia, i dilettanti, che sono "finalmente" arrivati al
moderno.
Andy Wahrol è presente come concetto. Piuttosto che la sua opera, è
la sua posizione rispetto all'arte e all'artista che è universale.
Innanzitutto i suoi riferimenti non sono più la storia dell'arte.
Il colpo di grazia a tutta la cultura precedente Warhol lo dà
quando dichiara che il suo desiderio ultimo è quello di diventare
macchina, di essere un obiettivo fotografico.
Le macchine non si oppongono a nulla, non criticano nulla. È
evidente il concetto di cyborg, al di là della letteratura, è
rimasto sempre aperto, perché è un processo in divenire in questa
fase post-umana. Siamo in una relazione sempre più stretta con le
nostre macchine e loro con noi, la situazione in atto che modifica
costantemente lo stato precedente delle cose, la sensibilità umana
e di funzione delle macchine. Arrivando a sentire fortemente se
stessi come macchine e amandole per ciò che sono - non tanto per
ciò che fanno, sarebbe troppo ovvio - in quanto nostre creature;
riempiendoci delle loro facoltà, pur evidentemente restando uomo,
si può tentare di arrivare a dare un volto giusto al desiderio
dell'uomo di diventare macchina. In realtà voglio essere un cyborg,
qualcosa di inedito, che non esiste, che non si sa nemmeno se ci
sarà. In questo passaggio, che è tutto interno e non è razionale,
in questo camminare - tornando nel recinto dell'arte, della pittura
- si può dar luogo ad un uso macchinico degli strumenti della
pittura. Perché non usare direttamente la macchina? Perché
l'ipotesi è l'incontro, la nuova creatura, il mutante. Non sei tu
che devi usare la macchina fotografica, è la macchina fotografica
che deve usare te; è questo rapporto pulsionale, inedito, rapporto
d'amore contro natura, simile alla zoofilia; si tratta di far
nascere un figlio da questo incontro. Ecco perché si può ancora, in
questi termini, parlare di pittura.
Che differenza c'è tra questa pittura e, ad esempio, una
foto ritoccata al computer con Photoshop?
È una mossa
delicatissima, questa, che trova difficilmente delle risposte di
tipo teorico; cerca piuttosto di farsi risolvere su un piano
dell'ineffabile, dell'intuitivo. Nessuno in questa storia d'amore
deve essere quello che è, cioè il computer che svolge il suo lavoro
e io che lo ritocco. Wahrol dice di voler essere una macchina, non
di voler utilizzare sempre di più le macchine; si tratta di dire
"io abdico". Non voglio più essere un uomo, voglio essere una
macchina - eppure sono uomo; e in questa continua contaminazione,
che è un processo che è appena cominciato, da ciò dovrebbe nascere
una nuova sensibilità, un'inedita posizione nel rapporto tra l'uomo
e la macchina. Tutto ciò che ancora porta tracce di separatezza e
distinzione non è il voler diventare macchina, ma piuttosto il
voler utilizzare le macchine. Già nelle prime fasi di questo
cammino si sente in modo molto forte il disgusto dell'Io, ci si
allontana spontaneamente, si è in una nuova dimensione, in
compagnia di cose che non hanno Io ma che funzionano comunque.
Quanti di questi giovani che verranno ad insegnare nella
scuola pensi che lavorino in questa dimensione?
Credo
nessuno. Questo mi dispiace, perché se guardo la vostra rivista non
trovo pittura e che lavorano tutti lavorano sull'Io, narrano con
l'occhio limpido della macchina, ma anche loro forse procedono
forse per istinto, perché sono in questa dimensione e, senza averla
teorizzata, si comportano già istintivamente così. È probabile che
quelli che noi avremo qui non lo siano, però non è detto. D'altra
parte noi dobbiamo fornire degli strumenti.
Come mai assistiamo al fatto che oggi il 90% della pittura
oggi è figurativa, di narrazione, o anche se è astratta comunque si
tratta di un astratto un po' fumettistico, che mantiene
dell'ironia, dei riferimenti all'immagine della realtà che, pur
scomparsa, ci rimane negli occhi?
 La prima
questione è che in questo nuovo territorio non nominabile, del
quale non abbiamo la topografia e non sappiamo come si chiami,
abitano e si esprimono persone per sensibilità e istinto naturale
le quali hanno comunque un atteggiamento più macchinino del vecchio
artista. La macchina che rileva non inventa l'inesistente, il
fantastico, ciò che non c'è; rileva ciò che ha figura, presenza.
Dico questo non perché si servano della fotografia o del video, e
che hanno già questa sensibilità nuova, diversa, per cui vedono
l'esistente, esattamente come una telecamera. In secondo luogo
credo che questo avvenga non solo perché la macchina registra solo
ciò che si può vedere, ma perché credo che in questo mondo
post-umano ci sia grande capacità e voglia di comunicare,
comunicare in superficie - ma noi sappiamo che oggi la profondità è
tutta in superficie. C'è grande voglia di mettere in comunicazione
il mondo, le persone, le cose che sono immagini, perché le immagini
si attraggono, si chiamano, si amano, prolificano. E se io mi
riduco a macchina sono un'immagine e questo mondo è un mondo
angelico, non siamo più nell'umano. Prima di conoscere di persona
un giovane artista che vive dall'altra parte del mondo per noi egli
è un'immagine. L'accademia che ci apprestiamo a fondare potremmo
chiamarla "l'accademia angelica", è come un paradiso. Lasciato
l'umano alcuni credono che si vada verso l'inferno, per me si va
verso il paradiso.
La prima
questione è che in questo nuovo territorio non nominabile, del
quale non abbiamo la topografia e non sappiamo come si chiami,
abitano e si esprimono persone per sensibilità e istinto naturale
le quali hanno comunque un atteggiamento più macchinino del vecchio
artista. La macchina che rileva non inventa l'inesistente, il
fantastico, ciò che non c'è; rileva ciò che ha figura, presenza.
Dico questo non perché si servano della fotografia o del video, e
che hanno già questa sensibilità nuova, diversa, per cui vedono
l'esistente, esattamente come una telecamera. In secondo luogo
credo che questo avvenga non solo perché la macchina registra solo
ciò che si può vedere, ma perché credo che in questo mondo
post-umano ci sia grande capacità e voglia di comunicare,
comunicare in superficie - ma noi sappiamo che oggi la profondità è
tutta in superficie. C'è grande voglia di mettere in comunicazione
il mondo, le persone, le cose che sono immagini, perché le immagini
si attraggono, si chiamano, si amano, prolificano. E se io mi
riduco a macchina sono un'immagine e questo mondo è un mondo
angelico, non siamo più nell'umano. Prima di conoscere di persona
un giovane artista che vive dall'altra parte del mondo per noi egli
è un'immagine. L'accademia che ci apprestiamo a fondare potremmo
chiamarla "l'accademia angelica", è come un paradiso. Lasciato
l'umano alcuni credono che si vada verso l'inferno, per me si va
verso il paradiso.
E se ci chiedessimo a cosa serve questa accademia, la
risposta è?
A niente. Al puro piacere di produrre
immagini che si seducono l'un l'altra, che si attraggono. Anche
perché tutti noi in quanto tali non serviamo a nulla, anzi, a dire
la verità non ci siamo nemmeno, siamo immagini.
Fabio Cavallucci








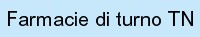









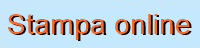







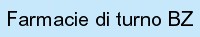

























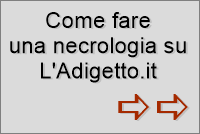
Invia il tuo commento