L’altra sponda del Mediterraneo in crisi. – Di Antonio De Felice
Breve analisi del presente, ma difficile previsione per il futuro
Nella terra dei gelsomini
cominciano a spuntare le erbacce.
A pochi giorni dall'inizio della rivolta che ha deposto l'ex
presidente Zine El Abidine Ben Ali, è arrivata la notizia che tutti
gli analisti temevano.
A darla è stato Jamil Ben Alavi, un importante leader degli
studenti tunisini, che secondo l'agenzia di stampa Fars, ha
affermato di «...essere ottimista riguardo alla promozione dei
valori Islamici fra la popolazione del Paese» e che «l'esempio
progressista degli Hezbollah in Libano può portare luce e speranza
per il popolo Tunisino...».
L'annuncio, che è arrivato proprio mentre migliaia di Tunisini
organizzavano preghiere di massa, è stato seguito dalla messa in
onda da parte di alcuni canali televisivi, de l'Adhãn la chiamata
alla preghiera.
Prossimo step: l'abolizione delle rigide norme varate 23 anni fa
dal «dittatore» tunisino contro il codice d'abbigliamento
islamico.
Il viaggio in Tunisia di Jeffrey Feltman, vice segretario di Stato
degli Stati Uniti, nonché più alto responsabile della diplomazia
americana per il Medio Oriente, è iniziato nel peggiore dei
modi.
Raccogliendo l'invito di Hassan Nasrallah (leader sciita di
Hezbollah) che da Beirut ha parlato davanti a una grande folla e ha
messo in guardia i tunisini a proposito del viaggio in Tunisia del
diplomatico, una folla di manifestanti lo ha accolto al grido di
«Feltman Go Home» e «USA let us free».
Prosegue la crisi libanese e si inasprisce il già duro confronto
tra la «Coalizione 14 marzo», che unisce i sunniti, l'élite
cristiana e i drusi attorno a Saad Hariri, e la «Coalizione 8
marzo», che unisce il partito d'ispirazione religiosa Hezbollah, il
movimento sciita secolare Amal, il movimento armeno Tashnaq, le
sinistre socialiste e comuniste e i cristiani meno benestanti
guidati dal generale Aoun.
Il cambio repentino di coalizione ad opera della vecchia volpe
Walid Jumblatt, capo dei Drusi, che dal governo è passato
all'opposizione ha portato alla caduta del governo Hariri figlio
prima e all'elezione poi (ieri) di un nuovo primo ministro: Najib
Miqati.
Si tratta di un miliardario sunnita nato a Tripoli, sostenitore
fino alle elezioni del 2009 di Hariri e che pur vantando da sempre
buoni rapporti con Ryad, ha scelto di schierarsi con la Coalizione
8 marzo.
All'investitura non sono seguite le rituali feste di piazza e,
mentre a Beirut è calato il silenzio della paura, da Tripoli a
Sidone migliaia di sunniti sentitisi traditi sono scesi in piazza
per protestare al grido di «Saad Saad» (Hariri) riaccendendo la
scintilla della faida interreligiosa.
Come abbiamo già scritto, Ieri era cominciata in maniera pacifica
al Cairo e nelle altre regioni dell'Egitto la protesta. Ma quando,
nella centrale piazza Tahrir è degenerata, sono pesantemente
intervenute le forze dell'ordine.
Un poliziotto è morto e tre manifestanti sono rimasti uccisi.
Un quarto manifestante e morto oggi 26 gennaio.
Oggi, nonostante il divieto imposto dalla polizia, il gruppo
denominato «movimento 6 aprile», tra i principali fautori delle
manifestazioni di ieri, ha esortato la popolazione a tornare in
piazza.
Diversa la posizione del movimento delle Fratellanza Musulmana che,
pur avendo ufficialmente dichiarato di non aver preso parte alle
manifestazioni di piazza Tahrir è stato segnalato molto attivo ad
Alessandria d'Egitto, la stessa città dove ha avuto luogo la strage
dei cristiani copti la notte di San Silvestro.
Ciò che sta accadendo in Egitto non è minimamente paragonabile sia
per importanza che per dimensioni a quanto è accaduto in
Tunisia.
L'Egitto è un Paese di circa 90 milioni di abitanti (il 50% dei
quali vivono in appena al di sopra della soglia di povertà fissata
dalle Nazioni Unite in 2 dollari americani al giorno), 10 volte di
più che in Tunisia, ma soprattutto l'Egitto confina a ovest con lo
stato d'Israele e a sud con il Sudan.
Se dovesse sgretolarsi il potere egiziano (e c'è da augurarsi
davvero che ciò non accada) sarebbe una vera catastrofe non solo
per l'intera regione ma anche per il bacino del Mediterraneo.
In questo scenario tutto da definire, spiccano le dichiarazioni di
Mohammed El Baradei, ex Direttore generale dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) e dirigente
dell'opposizione egiziana, che ha definito «inevitabile» un
cambiamento di regime in Egitto dopo la sollevazione popolare
tunisina che ha portato alla caduta del deposto presidente Ben
Ali.
«È inevitabile, il cambiamento deve arrivare», ha detto El Baradei
sottolineando inoltre che la situazione della generazione sotto i
trent'anni (che rappresenta il 60% della popolazione egiziana) «non
ha alcuna speranza, alcun futuro, ma neanche nulla da perdere,
contrariamente alle generazioni precedenti che convivono con i
regimi o che li temono».
El Baradei, filo Iraniano, insignito del premio Nobel per la Pace
(anche lui troppo frettolosamente verrebbe da dire), che da molti è
accreditato come l'unico possibile successore di Mubarak, ha
inoltre lanciato un appello al boicottaggio delle prossime elezioni
presidenziali, fissate per il mese di settembre e ha iniziato la
raccolta delle firme per una petizione nella quale chiede una
maggiore democratizzazione del Paese.
Giordania, Algeria, Barhein e Yemen, al momento sono solo
sorvegliati speciali.
Antonio De Felice
(Esperto di politica medio orientale e di aree di crisi
internazionale)








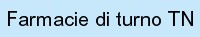









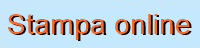







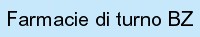

























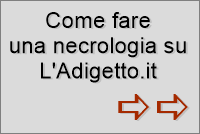
Invia il tuo commento